Il cuore del romanzo si erge con la dolorosa novella di Simone Pau, personalità insolita e magica e, che trattiene in sé la ‘trappola’ della vita e ne evince la fuga, passando per conclusioni speziate ed elegantemente intellettuali, che annuncia a Serafino Gubbio, il narratore silenzioso, il suo destino e l’apparenza se non la sostanza debole e miserabile della condizione umana; costruisce davanti ai suoi occhi il tragitto della storia e della civiltà del suo tempo e, procede in questo ufficio attraverso il violinista, uomo emaciato e ‘corrotto’ dalla sua stessa arte e dal suo stesso dio, il violino, che gli ha recapitato occhi troppo ampi per mettere a fuoco il lezzo umano e le sue disgrazie meccaniche che, l’uomo stesso ha creato e che ora deve sfamare con nutrimenti a buon mercato, ahimè.
Questi mostri meccanici, di cui siamo solo i maggiordomi, ci uccidono e ci deturpano il pensiero; questo deve aver pensato Gubbio certo molte volte. Il violinista reca la traccia umana nel suo momento più fertile e più nudo; trascendentale; racconta il sogno umano appena sporto, testimonia le nostre intenzioni, anche le più crude, prima della civiltà e durante; fa insomma , io credo, comprendere la specie umana nella sua interezza-il pensiero, il suo impianto e la sua capacità di astrazione e, l’umanità, che lo ha ucciso invece, altro non è che la trasformazione del pensiero, nel momento della sua apoteosi, a miseria, che ha il capo cinto di cattiveria: scarti di pensiero.
Gubbio è un uomo con una vivida consapevolezza, è un visionario ed è vulnerabile alla bellezza e al succo dolce che ne trapela; addirittura riesce a intercettare, sui lineamenti della Nestoroff, cammini di ombra o luce che intagliano il suo viso, rendendola per qualche istante ‘vicina a se stessa’; ”e allora ella aveva finto davanti a lui di provar fastidio, non già di me che la guardavo, ma del sole che, di tra i pampini del pergolato, la feriva in viso. Era vero; e mirabile su quel viso era il gioco dell’ombra violacea, vaga e rigata dai fili d’oro di sole, che or le accendevano una pinna del naso e un po’ del labbro superiore, ora il lobo dell’orecchio e un tratto del collo”.
Nonostante ciò, Serafino, è un operatore alla “Kosmograph”, la casa cinematografica patria di tutti i personaggi del romanzo, che dà il cibo alla sua macchinetta che porta la sua testa che egli porta dunque in mano perché sa che la vita non ha nessun nome e che i desideri umani vacillano e non trovano mai un giaciglio abbastanza ampio su cui sospendersi e farsi l’anima quieta. Dunque Gubbio conosce fedelmente Varia Nestoroff, la prima attrice della compagnia cinematografica e anche la donna che porta la morte persino a se stessa.
La Nestoroff è un calco degli dei, dei delle stragi, divinità belle e senza memoria, dal pensiero friabile e discontinuo e non figlia di un unico dio, che porta ristoro; lei porge la morte, l’ha donata, nella mansueta casetta di campagna di nonna Rosa e Duccella, a Giorgio Mirelli, suo amante e nipote di nonna Rosa e fratello di Duccella, perché “malato era d’una divina malattia” che in lei aveva infonduto e distillato, senza voler rintracciare in lei la sua ‘reale fisionomia interiore’; molti, in realtà, hanno amato solo il suo corpo ma quello che il Mirelli opera su di lei è addirittura una metamorfosi; instaura sul suo corpo, che egli certamente adora per quello che realmente è e vede, la sua idea; Mirelli sempre è portato a vedere solo quello che vuole perché “istintivamente rifuggiva da ogni distrazione volgare”; e così lei, la Nestoroff lo tradisce, munita appunto d’armi pagane.
Giorgio Mirelli è un artista o sarebbe meglio dire un esteta, cresciuto come un piccolo infante al fianco della sorellina Duccella e nel petto dei nonni; nonni che custodiscono i due giovinetti con l’animo e col fiato e che rifioriscono attraverso una vita di ’simil realtà’, screziata da azioni belle e nette e di un’opulenza che si genera nella grazia della semplicità schiva che pare quasi folle; “credette forse nonno Carlo che, tolta dal pilastrino la targhetta, la morte non avrebbe trovato più la via per ritornare?”.
Attraverso queste umanità, passano altre umanità, correlate strettamente alle prime e, quindi il Nuti, l’artefice e artefice anche lui della morte del Mirelli e amante nello stesso momento della dolce dolce Duccella che poi, diverrà, una figura che fa intendere in modo indelebile, l’idea che Pirandello ha dell’esistenza e del fluido vitale dell’anima nel suo perpetuo cambiamento, che quasi cangia gli aspetti e le ragioni di ogni cosa e che dunque, nessuna forma contiene un riferimento costante e, che dunque spiega l’arrendevolezza di Serafino rispetto al suo sentire concreto ma che, inevitabilmente, non lascia nessuna testimonianza che tuttavia, Serafino non può comunque smettere di investigare. Il Nuti dunque è un campione della ‘bellapparenza’ e del suo corpo ampolloso e incerato di fragranze di potenziale divo fa la sua sciagura; gli somiglia un po’ il Ferro, nella sua apparenza di uomo, uomini di un certo tipo di femmina; hanno quel coraggio da pellicola, cinematografico che quel tipo di donne alimentano; tutto finto, tutto vano, tutto subitaneo.
Tutte queste creature stanziate in una casa cinematografica o appena fuori come i Cavalena, la famiglia che ospita Serafino e il Nuti, sono l’incarnato dell’umanità nella sua modernità appena svezzata, lucida e rumorosa e nei suoi eccessi inutili ma non “superflui”. La scrittura, con cui Pirandello intaglia queste personalità o con cui intercetta un platano o “mani quiete e pure a cui offrire un pizzichetto di tabacco”, è di tessuto, il suo ritmo incalzante seppur sobrio, di rammarico seppur gioviale; è un mare leggero sulla costa perpetua; è una balia nelle prime ore della sera. E’ una stesura signorile, emancipata, coraggiosa, vitale; pura. Il suo giudizio è rapido e fresco come l’ironia, eppur accusatorio.
Pirandello rivendica la sostanza dell’uomo, il germe forte delle sue viscere che s’accuccia negli occhi, che dagli occhi, dove appunto fa la prima sosta, passa poi in tutto il corpo rendendolo vigile a ogni segnale vitale e pronto all’accoppiamento con la natura e con tutto quello che produce. Crede in una creatura che solo a contatto con le sue ‘ragioni’ può emergere o sradicarsi da certi volti inappropriati e tatuati anche se poi cambierà fisionomia senza mai coglierne una in particolare; ma è necessario un dinamismo che trae una sua forma dalle cose della natura che, non hanno una forma perpetua, per poter dunque disegnare sui propri lineamenti qualcosa che par possa somigliare a un viso e a un corpo frastagliati dal vento, mossi per via di un ‘incantamento’, proprio come l’essenza e, che venga poi di nuovo a contatto con un arbusto o un palmizio o un suono canterino per poter di nuovo porgere la sua forma a un cambiamento che porti il manifesto dell’onestà, contrariamente a tutto questo ‘operato meccanico’ che toglie i nomi alle cose e porta stupidità e spossatezza costruendo sulle nostre forme, forme immobili.
Serafino è felice sul suo carretto lento lento perché può guardare e sentire l’aria e tutto quello che la circonda e lui anche conosce la belva e i suoi meccanismi e, si è compiaciuto ad ascoltarla; ne ha tratto profitto. Serafino imposta l’assoluto e i suoi legamenti intorno al suo essere, se ne appropria, fa ratto di tutti i candori della vita e, come un bottino di guerra stende su di sé le voci e i fianchi della materia, facendo di questi le sue ‘maschere’ ma, lui anche, come i più miserevoli, è un operatore che “solo, muto e impassibile” fa l’operatore.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
GIANMARIA DE LUCA, OPERE
GIANMARIA DE LUCA, OPERE di Francesca Sallusti Ho conosciuto Gianmaria con la sua ultima opera “Roma: Camera Obscura” (opera
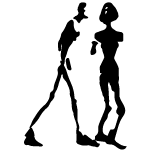

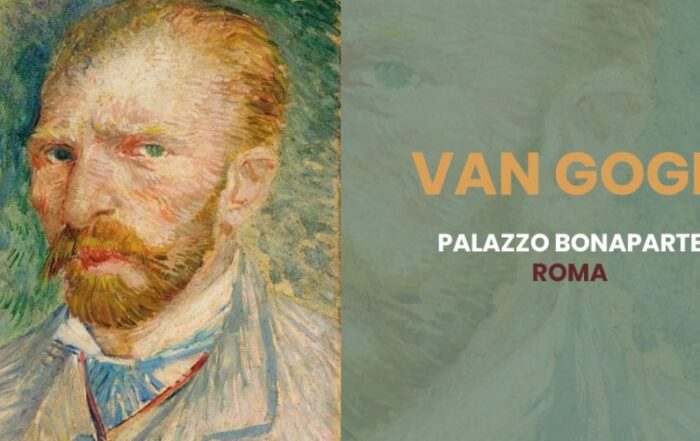


Scrivi un commento