L’opera di Amos Oz sembra essere organizzata e sviluppata per piani bidimensionali, proprio come in tanta pittura post impressionista, facendo dunque pensare al ‘sintetismo’ in particolare, un periodo della pittura di fine ottocento dove la pittura sopravvive grazie a elementi formali come la bidimensionalità e dunque l’abbandono totale della prospettiva, la percezione della linea sintetica e pura e il colore netto e uniforme. La fisionomia intima dei personaggi, il loro vivere e agire, l’ambiente in cui colloca i suoi personaggi, esotico e ricco di animali e vegetazione, fischi e venti che abbracciano il loro tempo fanno pensare molto alla pittura sintetista ma quello che lo ricorda maggiormente è come viene descritto tutto questo: i personaggi e gli animali vengono appena accennati, appena descritti, quel poco che basta per collocarli nel tempo eppure, la loro sostanza, una volta concepita, è invadente e fortemente poetica, perché pregna di dolore, di un dolore paziente e dolce, di una misericordia talmente lungimirante e esistente da rasentare l’indifferenza e la disattenzione e il disinteresse verso qualsiasi ‘costruzione umana’, ricordando addirittura Camus, ma questo lo vedremo dopo.
Quando descrive il kibbutz e la vita del kibbutz, anche quelle descrizioni, sono ridotte al minimo, elegantemente scarne, silenziose eppure anche qui, energiche, carnose proprio come appunto la pittura sintetista, in cui le figure emergono come ‘grandi masse’ stagliate sulla tela, dove la materia è costruita senza sfumatura né prospettiva e un grande masso, energico e potente, campeggia sulla tela. Questa sintesi del linguaggio è congeniale, in questo caso, anche per sottolineare la dimensione solitaria, se non astratta, dei personaggi rispetto alla comunità.
L’umanità di Oz dunque è penetrante a se stessa, ritagliata in una dimensione perennemente umana, quasi senza congettura di se stessa, dove la carne vive più dell’intelletto, delle idee, delle tradizioni, delle apparenze e di qualsiasi altra debolezza inventata dalla civiltà. Si stagliano queste figure sole, profonde, carnali e carnose, dubbiose e morbose.
Dunque torna Camus, che non a caso ritroviamo anche come lettura di un personaggio di Oz in questo romanzo; non sarà stato un caso certamente l’avere trovato Camus come omaggio in questo romanzo e l’aver anche rilevato il suo spirito e la sua sostanza nei personaggi.
Torna Camus nel disegnare le figure stagliate solo nel cielo e dal cielo, sole, ‘disgraziatamente e dignitosamente accontentate da sé stesse’, dal dubbio umano che è l’unica spiegazione a cui si può accedere. L’umanità di Oz è ritagliata minuziosamente in un disincanto dolcissimo e nelle sue conseguenze, conseguenze che portano inevitabilmente e se si ha il cuore, all’accettazione della vita e del suo idioma senza alterazioni individuali e senza sogni intimi ma ascoltandola, lievemente, gota a gota. Molti personaggi sono intrisi di questa disattenzione, come in Yotam kalish, il ragazzo che vuole andare via dal kibbuz ma senza slancio né destinazione, “ma nei suoi pensieri è affiorata d’un tratto l’espressione ESTRANEO A SE STESSO.” Si tratta di una accettazione intelligente, strutturata, che ha a che fare con ‘una certa riservatezza dell’impossibilità”, una impossibilità voluta e non subita, una accettazione che ha a che fare col moto incessante del divenire insito in tutte le cose ‘che esistono’.
La scrittura di Oz espone un tempo a noi sconosciuto, che si colloca tra qualcosa che è umano e qualcosa che non lo è, tra la coscienza e l’istinto, esplorando una dimensione spirituale, arcana e perennemente nuova, lasciata indietro; un’era vecchia più della vecchiezza e nuova più della morte e dunque incontaminata, pellegrina, più fresca della ‘freddezza’ e più solida del caos e del silenzio.
E’ imminente il tempo che separa le due dimensioni, è sottile e soave, a volte impercettibile ma violentemente contrasto e contrastante e complicato da ascoltare perché contaminato dalle strutture e dalle gerarchie sociali che di fatto emergono, ma la delicatezza del suo canto si sofferma proprio qui: sorprendere le gracili dinamiche del suo incanto tra le incongruenze addomesticate che si presentano come masse plastiche della quotidianità, o mantenere il sogno, terreno e primordiale, per via di un’educazione alle cose battute e vissute. Una vita che si presenta ogni mattina puntuale e senza sorprese e che, per via di queste vite, si caratterizza, si snoda dalla vita stessa pur rimanendone incisa.
Questa condotta umana che Oz traina è visibile anche nel creare le stesse attitudini nei diversi personaggi, come a generare un microcosmo di incantevole delicatezza che si difende e si autodefinisce.
Questo romanzo è la prima opera che leggo di Oz e al di là di tutto quello che ho rilevato rimane un linguaggio piatto e epigrammatico e per questo nuovo, distaccandosi nettamente da una dimostrazione minimalista come si potrebbe pensare e aprendo un discorso, del tutto innovativo, di una scrittura che pare voler avvicinarsi alla pittura, appunto sintetista e anche cubista “Ha bevuto un caffè, ha tagliato due pere a fette regolari e tutte uguali..”, e che si poggia su un modulo di pensiero esistenzialista e che non ha niente a che fare con la religione e qualsiasi altra congettura.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
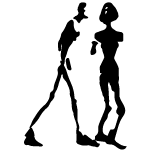


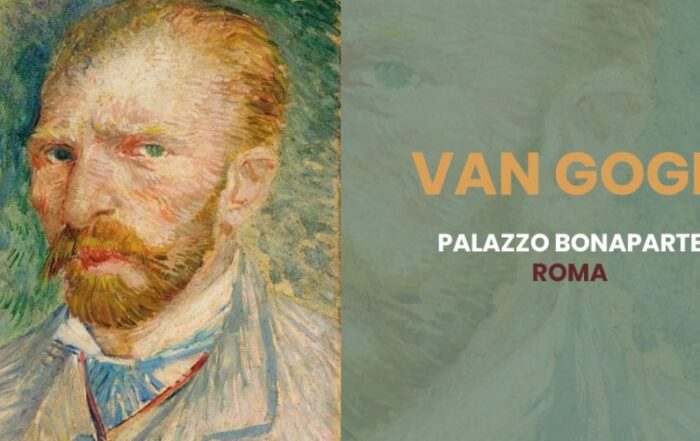

Scrivi un commento