La lingua terrena, penetrata da gerghi dolci e vagabondi come germi o batteri, rendono tanto forte e vitale il fiato di Pavese, intriso di pensieri strutturati e vigorosi, leali. Lo splendore riposto nella sua parola ‘dimessa’ e acuta è vorace, è una fratellanza nella solitudine, è uno sposalizio nella perplessità dei sentimenti, è un ornamento necessario e non agghindato nella totale dimensione poetica che acquista sacralità perché tutto prende.
La dimensione che ci inoltra è un’umanità coordinata e robusta che senza dubbio prende posto nel suo cantuccio freddo e oscurato dalla freddura della vita e del suo tempo che assolutamente non dimostra scientificamente ciò che fa. Pavese scrive come si respira, come il respiro è armonioso in un meccanismo vitale; si genera sopra a intendimenti destinati a episodi mastodontici attraverso un respiro franco e sano; come un giovane smaltisce le sostanze del giorno sulla collina affumicata dalla linea nera a ’notte.
E’ un uomo, Pavese, che si riflette nella malleabilità dell’esistenza e dei suoi risultati e che fa dunque della parola una sostanza libera e audace e degli avvenimenti che, dentro la parola si rifugiano, una ninna nanna eterna o un’espressione per sempre immatura; è un’espressione, la sua parola, dichiarata e protetta dal focolare materno e paterno, è uno slancio pericoloso e arginato dall’amore. Quasi che tra poesia e narrativa non ci sia una tale distanza, tale è la sua consapevolezza della comunicazione.
Nel romanzo “La bella estate” il ritmo si converge in una sintesi poetica, proprio per la sua capacità o volontà o ‘noncuranza’ verso la bella forma, di dare tono e speranza e conformazione a una lingua libera, sperimentale, come lo può essere un relitto da maneggiare e scrostare; (come se la sua lingua si rifugiasse tra la ruggine) e estrapolata e inafferrabile che il pensiero richiede. Tutto si allinea nell’origine e sull’origine e dunque, nella natura e nelle sue pianure, colline, nei suoi campi e nelle sue fonti, nella giovinezza come esperienza virile della natura e nel ricordo, sentito come primo meccanismo del pensiero; sorge, tutto ha inizio anche se si elabora nella nostra vecchiezza o durante un qualsiasi corso della vita già matura e lontana dall’origine; ma la sua scrittura si colloca nell’origine e l’elemento onirico dei vuoti, del silenzio, della luce la rende intima e calda. Anche i “villani” rendono percepibile se non possibile questo disegno. Quasi una manovra biblica cucita da una parola dimessa e nutriente.
Le donne campeggiano come una dinamica nella dinamica, come enti estrapolati dalla propria identità; appaiono necessarie e tanto belle o forse autoritarie ma incastonate come elementi superflui, come un horror vacui; quasi a denunciarle. La grazia che sudano è una colpa o un suggello. C’è Torino, la città beccata dalle pianure, dalle colline e dai fiumi; la città braccata dalla natura di Pavese e da dove, camminando un po’, si riesce a ‘uscirsene’ fuori e starsene un po’ più vicino alle stelle attraverso una collina e rivedere Torino che si è appena lasciata alle spalle. Ci vanno le donne, ci vanno le ragazze e ci vanno Ginia e Amelia a deporre le loro sporcizie, a rinfrescare i ragionamenti, come se questi fossero piazze squartate al cielo.
Torino è un cuore dilaniato, un caro pensiero sfilacciato nella luce tenue di una città; somiglia a una apparizione sperata e mai configurata o pare una traccia geografica che s’irradia a noi; a dove siamo, ed è esattamente o, pare volerlo essere, il confine tra esasperazione e liberazione. È l’unica e giustificata entità alle pendici del cielo e l’ultima ragionevolezza che porta alla freschezza delle stelle.
Spesso la natura di Pavese è una natura che dialoga, è una natura ‘umana’, fatta dall’uomo, impastata dall’uomo, che emerge dalle sue creature, come se fossero queste creature a innalzarla o porgerla in una natura, tanto è sporcata dai sentimenti dei suoi figli che, la riducono a una proporzione monca del loro fluire o del loro fluido; tutto smette di essere natura per ricrearsi in una nuova natura che non ha quel nome per poi, senza un tempo che, può essere piccolo o maturo, ritornare natura generatrice a cui i propri figli disperati e affamati attingono.
“La compagna non vede la nuda collina assopita nell’umidità”, la natura che ci presenta è qui di nuovo generatrice, è un tempio in cui limare i propri fianchi, è un tempio sempre vicino in cui buttare i propri occhi come un ritorno di un fedele dopo un viaggio, come un seme nel suo posto sta, come l’unica condizione conosciuta e riconosciuta dove il lecito acquista un valore fondamentale e incorruttibile; il lecito di saperci vivi in questa dimensione, giusta o sbagliata che sia, senza domande e, raccolta in un sonno perpetuo e invincibile. Il suo cosmo trattiene in sé un canto illogico, dormiente nella trama umana.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
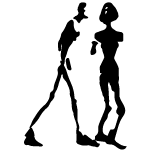


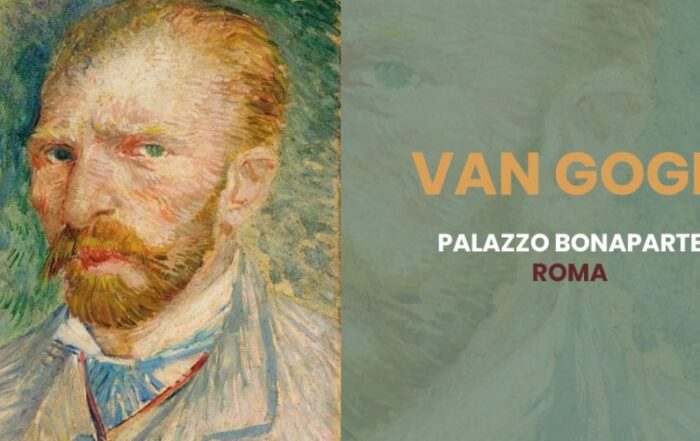

Scrivi un commento