“Io farò una finzione, che significherà grandi cose”. L’iscrizione dedicatoria a “Le Vergini delle Rocce” è un’affermazione slanciata e nervosa e tuttavia breve e candida della sua letteratura, anche se, in questo caso, per la sua collocazione, ha una destinazione diversa che poi più in là vedremo e, che ha a che fare con il tentativo virtuoso di Claudio Cantelmo di ergere, per via di elezioni, su una nuova rotta, se stesso.
E’ vero infatti che D’annunzio progetta e crea un artificio velenoso che raggira, ubriacandolo, il cammino del pensiero che, è costretto a fermarsi. La sua è una scrittura che inibisce il flusso del pensiero e inebetisce la sostanza morale e la sua capacità e sfalda la nostra memoria con l’approdo di un’altra memoria, una memoria scolpita dalle immagini deliziose e dunque provvisoria: una memoria estetica. Questa è “un’attitudine” di cui si serve costantemente sia all’interno dei suoi testi e in questo caso con le tre vergini sorelle per vivificarle forse o per appassirle, sia all’esterno con il lettore.
“Io farò una finzione, che significherà cose grandi”; è vero infatti ancora, che la parola di D’annunzio, (così come le eventuali azioni, che rimangono ‘idea scolpita’ in un giaciglio scavato nella regione del pensiero e, trasmigrato poi in una ‘azione’ rarefatta, pensata dal pensiero stesso e che diventa intento e tentativo), attua un progetto vitale parallelo alla vita reale e si rivela eloquente, denso, speziato.
L’opera di D’annunzio è plastica al punto tale da affermare addirittura che non si tratta di letteratura ma piuttosto di un’opera d’arte, una scultura sotto al cielo a volte e, a volte un panneggio cinto da un torpore divino. Nei suoi testi non si legge la parola ma si ascolta il volume delle forme.
“Una cosa naturale vista in un grande specchio”. Un’altra iscrizione posta all’inizio del prologo, quel prologo che contiene l’incontro di Claudio Cantelmo con le tre sorelle rigettate dalla vita e migrate in un perpetuo, folle e materno fianco. Dunque nel prologo un incontro sublimato da un pellegrinaggio verso una destinazione eterna e ultima, secondo il suo disegno di superuomo. In questo pellegrinaggio destinato alla creazione di un nuovo sovrano, del più potente sovrano, attraverso tre donne che portano dentro i semi della forza, come capacità di reinventare la stirpe vigorosa assopita e di perpetuarla con una sorta di virilità, osteggiando così la viltà umana, i semi della memoria, come ostentazione divina della regalità, e i semi della fede, come patina soave in cui suggellare i più “spirtali” proponimenti; attraverso tre donne cinte dall’antico giardino, Claudio Cantelmo compone un ornamento infinito, cercando così un’unica identità da trarre a sé, che tuttavia non trarrà.
Dunque Anatolia, Violante e Massimilla, tutte e tre le creature sono un’unica sostanza del progetto di Claudio, progetto che è stato tramandato a lui da Socrate (e qui torna la finzione come attuazione di plasmare, attraverso il rigore, il proprio destino e quello del mondo di conseguenza) e che afferma che una civiltà è il connubio composto e armonioso di stile dunque la forza di un’orma certa e inalterabile, di piacere come attitudine di grazia e propria delle Grazie, delle Ore e delle Ninfe che rifuggono lo sforzo sterile e quella ‘necessità’ umana della produzione come rivalsa e di fede come cavità profondissima in cui riporre gli slanci e nutrire “quella forza nativa” con il calore ardente della generosità. Sembrano propagarsi nelle tre creature le fisionomie del maestro, a tratti sembrano apparire come la dolcezza del miracolo o come un ciclo vitale che riaffiora. Invero il pellegrinaggio di Claudio Cantelmo non troverà approdo, rimarrà cammino duttile e sensuale come il demonico gli aveva sussurrato. Il sogno rimarrà sogno che nella sua fine si rigenererà.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
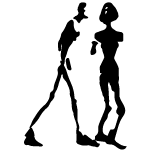


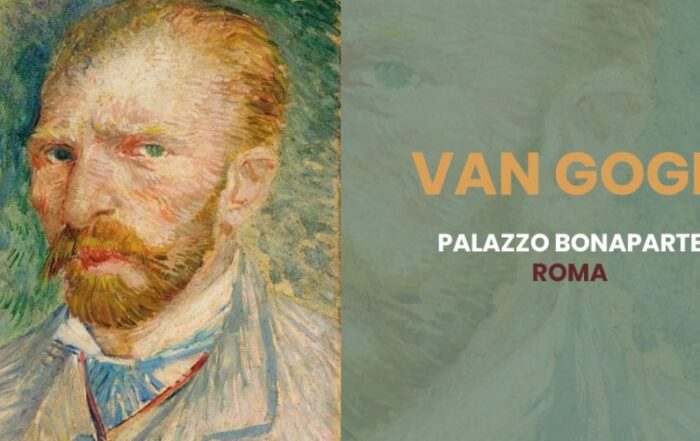

Scrivi un commento