Il libro comincia nel fango e finisce nel fango. Tra fango e fango, tra “preme il sangue nel fango fetale” e “i topi battono la coda nella melma, /dove striscio la pancia battono la coda”, falls the silence. Ovvero, non v’è nulla. V’è anzi il regno della “non nascita”.
Se per Mallarmé il destino del poeta moderno era quello di cesellare il proprio sarcofago, per Tipaldi la soluzione è più drastica e sta nel rifiuto della nascita: “è un tempo triste il nostro, bloccate le nascite”. In ciò Tipaldi sembra concludere – quasi ironicamente – una parabola di “soluzioni vitali” (si fa per dire) che dal romanticismo ha attraversato le grandi poetiche della modernità: generazioni di malnati, di suicidi, di “nati soltanto a morire”, per arrivare alle recenti “Poesie della non morte” di Ricciardi, in cui parla la voce di un “non abitante” di una condizione che è definibile soltanto per via negativa.
“Quello che era non è
e quello che è sta per non essere – c’è da sbrigarsi
sbrigarsi a morire.”
scrive Tipaldi, il cui libro d’esordio aveva per titolo “La Culla”. Qui si torna ancora più indietro, si è risaliti allo “Humus”, quasi che la figura del rifugio nel mondo dell’infanzia non fosse più sufficiente a contenere la pulsione metafisica ed escatologica della poesia.
Il poeta che parla all’inizio di questo libro è un “morto alle prime armi” (come scrive altrove Tipaldi), un feto incaponito nella sua posizione (“Avevo la fronte sulle ginocchia”), e il suo mondo è un grembo di fango e di buio: “Ho associato il grembo al fango ed il fango al buio.”, “appartengo al fango”, “il fango mi teneva caldo”. Tipaldi, nel fango, corteggia la “non nascita” e desidera indugiare nella condizione che precede la determinazione formale, l’individualità, e con queste la responsabilità e la possibilità della colpa. Per questo il libro non ha inizio, e non ha fine, quasi fosse anch’esso “non nato”: ogni immagine non è che l’eco della precedente. L’indugio nella “non nascita” è l’indugio nella hyle, ossia nella “potenza”, nel dinamismo dell’indeterminato. Ma non è qui un concetto, non un vagheggiamento, che troviamo. Bensì è una rapsodia, un concerto (il rimando alla musica – alla “non parola” – è continuo ed esplicito nei titoli delle sezioni e dei componimenti). Non leggiamo la noiosa poesia della materia (o del materialismo). V’è bensì il canto delle mille voci, e, in esso, ciò che più ci importa, una vicenda umana che porta dall’indugio nella “non forma” della “non nascita”, alla soglia della visione di una luce “non umana”. Non siamo qui – Dio sia lodato – davanti a un “poeta dell’inorganico”. Neppure stiamo leggendo un inno neo-pagano alla materia madre. “La materia organica / tende a marcire dopo pochi giorni.”, scrive altrove Tipaldi e fa sentire chiara l’eco di un certo empirismo tardo-barocco e illuminista che torna, acre, per tutto il libro. La preoccupazione di Tipaldi è decisamente escatologica e metafisica. La “non nascita” è soltanto una ipotesi dell’intelletto e della immaginazione filosofica: “Come sarebbe stata la non nascita, o neppure?” chiede Tipaldi. Proprio come ipotesi, come possibilità o limite delle possibilità, essa è terribile. La vicenda della materia, il continuo ribaltamento di vita e morte che in essa – come in un sostrato – si attua, sono la matrice bifronte di questa poesia: la culla, la bara, e pongono un problema alla volontà umana. Ossia un problema etico.
Ma abbiamo in mano un libro di poesia, non certo un trattatello filosofico. Per tanto in queste pagine il regno della “non nascita” è fatto vivo, il feto-poeta ci sprofonda nel suo fango allegro, ci invita alla lode delle “molli latrine dei maiali”, con un canto che è come un rosario, in cui sentiamo la voce vitale dei dissipati russi del secolo scorso, l’eco di Chlebnikov, e dove, come in un vomito, non possono stonare omaggi, citazioni, finanche inserti: da Eliot (“quel lamento materno, quell’orde di uccelli che sciamano / su pianure rosse-terra / gli uccelli / con facce quasi umane, di scimmia” che richiama alla memoria interi brani de La Terra Desolata, i “murmurs of maternal lamentations”, i “bats with baby faces” etc.), da Kafka (“gli tirarono le pesche / […] aveva una pesca nella carne / quella mattina.”), da Campana (il “sangue di viola” ripetuto lungo la poesia “162” è certo un’eco della “sera d’amore di viola”), da Rimbaud. Pur senza l’insistenza analitica del poeta decadente, Tipaldi ci affresca il suo lieto e feroce Maldoror della “non nascita”. Il poeta “non nato” predilige i cibi molli, i cibi malleabili, i cibi modellabili. Pane, formaggio, cachi, paste e pasticcini, “come dire buio / ciò che non accade, il non fatto / molle, di gelatina”. Ama la torta, i bigné. Le “fresche e dolci paste”. Al regno della “non nascita” pure appartengono gli animali che tanti percorrono il libro. Ed è proprio seguendo questi animali “di buio in buio”, ci sembra, che possiamo iniziare ad attraversare questo libro. Galli e galline, i cani e le balene. Le scrofe. Tutti gli animali della “non nascita” sono ambivalenti e sono animali della soglia. I galli, le scrofe, i cani: simboli antichi della fertilità, del vigore riproduttivo. Le scrofe e i cani figure dell’impuro per la cultura giudaica e poi cristiana e islamica. I galli (per i Greci, per i Germani) e i cani guide per l’aldilà. Il gallo ancora simbolo della resurrezione sopra i sarcofagi dei primi cristiani. Non è un caso dunque che siano proprio queste bestie – infoiate e psicopompe, salvifiche e impure – a condurci verso il cuore di questo libro. Al cuore di una vicenda che riguarda la volontà e la scelta.
Un primo vacillamento del volere s’esprime proprio nell’avvicendarsi delle bestie ambigue, nell’insistenza del loro ritornare, nei loro continui ribaltamenti: la balena – fondamento del mondo – vola sulle montagne, e infine innaturalmente “affoga”. Come può affogare un animale marino? La “non nascita” è una condizione paradossale per l’intelletto e blasfema per la volontà, una sorta di “peccato della volontà” peggiore del suicidio. La “non nascita” in Tipaldi è – oltre che una pulsione continuamente riaffermata nelle figure del tepore casalingo e infantile (il poeta è sempre un “nipotino”, ama prendere il the con i biscotti) – una interpretazione della vita. Non vogliamo dire una allegoria, piuttosto una ipotesi filosofica. Quasi che – per dirlo coi termini della tradizione cristiana – il mondo non fosse altro che un grembo – buio e fangoso – nel quale nuotiamo come feti in attesa della vera vita. Come se dovessimo nascere per la seconda volta dal grembo della vita – che è una morte – alla luce dell’eternità, la vita vera. Detto altrimenti la “non nascita” è il regno dei fenomeni, il mondo che contiene tutte le forme ma che, se visto dall’esterno, parrebbe in esteso come un punto; è la giostra di distruzione e creazione che ci fa da schermo alla luce del vero. Shiva è appunto anche il “re dei cani”. La ruota della “non nascita” di Tipaldi è mossa naturalmente dal motore immobile del fuoco, dalla fiamma che “non consuma” ma che “consuma gli uomini silenziosamente”. Allora è chiaro perché, in questo grande e confuso indugio, la scrofa e il cane possono significare salvazione o dannazione. Gli uomini possono trascolorare in maiali, proprio alla luce del fuoco: “la signora con le mammelle sull’ombelico/ aveva il collo e le caviglie / dei suini. // Attorno al fuoco sembrava uno di quei vecchi / maiali”.
Tutto dipende soltanto dalla scelta. Forse è proprio davanti al problema della scelta etica che Tipaldi vuole metterci, con questo libro scherzoso e terribile: “o si vive o si vive nella morte”. È forse con la percezione del tremore e dell’esultanza della volontà, del grande tremolare della vita umana prima della determinazione che Tipaldi ci vuole confrontare. Un’altra apparizione del cane sembra suggerire proprio questo: il problema escatologico è un problema etico, la nascita è una scelta e la determinazione del mondo – per l’uomo – dipende dalla determinazione della volontà. “Nonostante il contadino urlasse / il cane continuò a defecare – pur volendo / non avrebbe potuto fermarsi”.
Sul piano dello stile, l’indugio della volontà nella “non nascita” si esprime in continui e subitanei cambi di punto di vista (soggettivo vs. oggettivo), di registro (da biblico a famigliare a colloquiale e ritorno), di tono (apocalittico, scherzoso, colloquiale, etc.), come anche nell’abbondanza di incisi (quasi asides teatrali), nelle irruzioni di brani di discorso diretto, di interlocuzioni o esclamazioni. Lo stesso scantonare da giovane animale del verso di Tipaldi si ritrova nella figura che l’autore predilige: un ossimoro prima di tutto “concettuale” – in cui l’opposizione è tra il materiale e l’immateriale (più che tra il concreto e l’astratto) – e solo in seconda istanza rinforzato dalla distanza dei campi semantici nei quali vengono scelti i due termini dell’immagine (“l’adolescenza si muove inzuppata”, “l’anima uterina”, “la farina del tuono”, “il nulla […] puzza di cane”, “parole di fango”, etc.). È d’altronde il poeta stesso a dirci che la sua vocazione è proprio questa: “Mi piace impasticciare parole e rumori, / come sputi con il fango.” Questo impastare parole e fango in parole di fango sembra rispondere anche ad una necessità più alta, che è forse propria di tutta la poesia: la necessità di dare a ciò che è immateriale e significante la concretezza e l’efficacia di ciò che è materiale e indifferente.
Con ciò torniamo alla prospettiva etica ed escatologica sopra accennata, e in tale prospettiva questo libro ci mostra forse il suo viso tremendo, spogliato degli stracci variopinti, spossato dalla propria goliardia, viso tornato serio dopo una gran risata, spente le “arie da un matrimonio”. La determinazione etica è ineludibile, irreversibile, e può essere fatale. Resta soggetta, diremmo quasi, ad una sorta di “principio di indeterminazione” metafisico. “A rincorrere cose già fermate non ci si diverte / – c’è un calzino sulla serranda – / Dopo il mio bonbon spero di centrare la tazza”. La determinazione della volontà è un azzardo anche perché il mondo è continuamente ribaltato su se stesso “Mondo vivo, materia viva, mondo morto, materia”, e il principio del mondo è continuamente scalzato dal mutamento che esso produce, resta indeterminato proprio nell’incessante attività di produrre nuove determinazioni “La fiamma danza senz’ombra. / La fiamma non porta l’ombra […]”. Il soggetto della scelta etica è dunque sempre in movimento, e il bersaglio della scelta etica si può sfiorare solo asintoticamente. Che lo si dileggi con un corollario impudico della sua onnipotenza (“Dio deve avere mutande perfette”), che se ne paventi l’aridità del giudizio infallibile (“nella bocca di Dio v’è distesa di sale”), o che ci si intenerisca per il suo fare da buon contadino che mostra i frutti del lavoro (“Dio presenta al mondo le sue lattughe”), è sempre Dio il destinatario delle interlocuzioni di questo libro. La tazza che Tipaldi vuol centrare, con la carta della sua caramella, è Dio. Anzi, come nel De Ludo Globi di Nicola Da Cusa, Dio è la (im)possibilità stessa di centrare la tazzina. La poesia di Tipaldi è una preghiera, ma il poeta “non nato” “come l’uomo non ha mani per pregare / e con la testa a terra prega di nascosto”.
Tutta la poesia di Tipaldi è questo gesto ripetuto, una partita al “gioco delle bocce” cui Cusano paragona la conoscenza umana, in cui mai si può ripetere due volte lo stesso tiro, in cui la traiettoria è sempre inevitabilmente nuova e il bersaglio sempre infinitamente lontano. Tipaldi è un poeta moscone e sbatte contro il vetro della verità fino a stordirsi. La sua testardaggine è pure la nostra condizione. Lo slancio verso la luce (un gallo era presente alla nascita di Apollo) è sempre un azzardo. E la luce ci accecherà: “i cieli non sono umani” scrive Tipaldi in una delle poesie dell’ultima sezione. Nella rivelazione, nella contemplazione del vero, starà anche la nostra dissoluzione. Anche per ciò il poeta indugia, indugiamo noi, torniamo come i cani al nostro vomito, come le scrofe lavate al nostro brago. L’ultima sezione del libro, “Visionen”, parla proprio di questo: di come potrebbe essere la luce. Di quanto poco consolatoria potrebbe essere la nostra liberazione, dopo la scelta. Fastidiosa come il canto del gallo. Dolorosa pure e lacerante. Perché la luce, della quale si presenta e insieme si scongiura l’eruzione, è “non umana”: “la luce cancella, dannatemente / cancella.” L’uomo, il poeta, potranno uscire dal buio e dal fango della “non nascita”, e della “non identità”, dove tutto è dolcemente mescolato, solo per accedere al regno della luce, in cui l’identità è di nuovo impossibile, ma per la causa opposta: perché la luce separa e scompone e con ciò dissolve i composti, annichilendo ogni principio di individuazione. A parte subiecti la luce cancella perché acceca. Il principio che rende possibile la visione la rende pure impossibile. L’avvento della luce coincide con l’inizio del tempo. I corpi non potranno più cullarsi nell’eterno indistinto della non nascita, saranno esposti alla successione del prima e del poi, ossia alla giostra del non essere mai. “E venne la luce, / e prese il tempo e le carni / tremendamente prese / le carni”. La luce separa e divide e dunque moltiplica e disperde. In quanto principio di divisione la luce è legata al linguaggio: “Venne luce / parlava le lingue, parlava / ogni lingua del mondo”. Il poeta è qui molto rapido, perché parla di una luce che si può soltanto intravedere: “Silence! And preserve respectful distance”, recitava un verso di Eliot posto in epigrafe a una penultima sezione più tardi eliminata. Ma Tipaldi è qui anche molto esplicito nel ricordarci che la natura “non umana” della luce non può scusarci dalla necessità di una scelta. Ancora: “o si vive o si vive nella morte.”
Tra il fango di buio che è all’inizio del libro e il fango di luce che s’apre alla fine, sta tutta la vicenda dei porci, dei cani e delle galline, delle figure della soglia che indugiano e traghettano, sospese nell’istante della scelta tra ritornare al proprio vomito e l’andare a rintronarsi contro il muro della verità. Vicenda di chi pecca dopo aver conosciuto la giustizia. Nostra vicenda. “Si è verificato per essi il proverbio: Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago” (Pietro 2, 22).
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
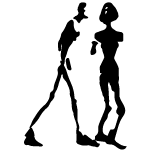


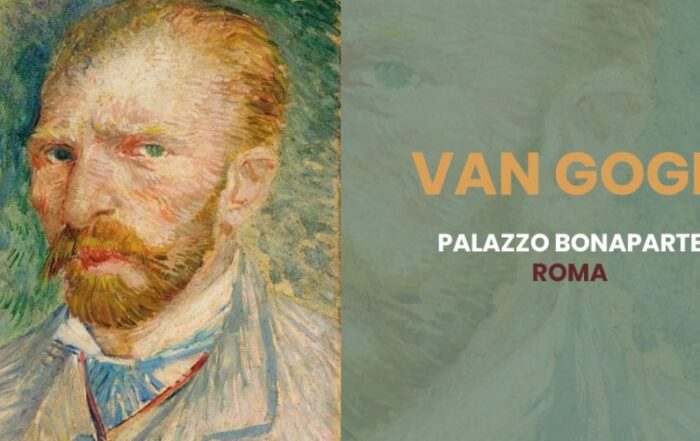

Scrivi un commento