Panasonica, il libro di cui ci occupiamo questo mese, ultima fatica di un giovane poeta, Simone Di Biasio, che ha già all’attivo militanza ed esperienze poetiche invidiabili – è un libro che viaggia su due canali che si intersecano di continuo, tanto che parlarne può apparire arduo, invece è uno stimolo intellettuale rilevante.
I due piani di cui parlo sono quello linguistico, che ci introduce in lunga e sofferta riflessione metapoetica che attraversa tutta l’opera, e quello esistenziale-esperienziale, che in quello linguistico si specchia di continuo. In pratica, l’io pensa se stesso in relazione a una lingua, che coincide anche col suo passato, col suo essere infante e adolescente, la Lingua madre (titolo, non a caso, della sezione centrale), il dialetto o la lingua dei vecchi, dei decaduti, dei sommersi. Il dialetto del luogo dove è nato l’autore, Fondi, patria del grande Libero De Libero.
I richiami a questo antico modo di esprimersi sono innumerevoli. Si direbbe che Di Biasio, che non si pone il problema di coincidere con l’io poetico, cerchi letteralmente di trasportare in tutto o in parte la lingua dei suoi nonni, il suono panico di un’età mitica che trascende quella della singola esistenza umana, in un mondo di linguaggi molteplici, disgregati e disgreganti, in un italiano globalizzato e sterile, senza più espressione né sentimento di sé. “Saper dire è una ferita aperta”, scrive l’autore, ed è infatti una ferita osservare con occhio lucido la fine di una lingua che coincide con la fine di un’era, la fine di un modo di essere insieme, di vivere e convivere in ciò che una volta si chiamava civiltà. In questo senso “il passato è un’innovazione da inventare”, perché sebbene giovane, Di Biasio comprende benissimo che senza radici la società s’incarta, non trova più la via di esistere in modo autentico e affettivamente valido. Quello che resta quando ciò accade, è sotto gli occhi di tutti.
E dunque? Dunque valga per ognuno un programma ‘panasonico’, un sogno forse, quello di tornare alle leggi eterne che regolavano la civiltà contadina intravista in luoghi rimasti (grazie al Cielo) appartati, dove le cose avevano un peso esatto e i valori non erano a scadenza giornaliera. Ma come potrà sentirsi un autore, un uomo che abbia compreso questa verità così difficile da condividere col nostro mondo a 5G? E qui si passa al dato esistenziale. Il soggetto è precario, disincantato, solitario. La sua vita è fatta di frammenti, e non potrebbe essere diversamente, perché la via della salvezza, per l’individuo come per la lingua, passa per la frammentazione obbligatoria dei dati di vita e arte che si costituiscono parallelamente in poesia. Che sia l’incontro con una donna o una visione al crepuscolo di Roma, gran Babele di razze e lingue, l’io si ritrova come in un mondo non del tutto proprio, un po’ ospite, un po’ bandito, ma sempre lucido nel suo intento di non dimenticare chi si è e da dove si viene.
In questo senso, anche se potrebbe sembrare il contrario, l’io si pone in una situazione quasi eroica, di certo abissale, pronto sempre a evadere, perché non è solo la lingua dei morti a essere sparita: dal mondo è stata espunta ogni traccia di benessere, di autenticità, di calore umano gratuito e disinteressato, e non si può sempre far finta che non sia così perché nel frattempo il tempo è passato. Pasolinianamente parlando, bisogna resistere, bisogna riportare in vita, almeno sotto specie poetica e letteraria, quel passato di bellezza ancestrale, che segnerebbe la svolta e il ritorno della Storia a quote di maggiore umanità, e forse alla salvezza stessa della specie umana.
La panasonìa di cui si fa riferimento nel titolo è un altezza superiore dell’udito, che nel rumore infernale da bolgia dantesca, riesce ancora a sentire un brusio di realtà alternativa, sia per la lingua sia per l’esistenza, che sono così legate da poter dire che l’una non possa esistere senza l’altra, che basta cambiare una vocale o una consonante e il flusso del bene riappare, insomma la lingua panasonica di Di Biasio, è, contemporaneamente, la lingua di una molteplicità satanica e furiosa, di un passato da rimettere in circolo nel nostro sangue, di una vita che non vuole perdere le sue fondamenta e la sua fonte da cui trarre la forma dell’essenzialità.
Per questo libro così ambizioso, poeticamente sonoro come pochi, abbiamo un augurio da fare: che la sua strada sia più facile di quanto si possa prevedibilmente considerare, e che la cifra di un giovane autore che avrebbe potuto battere sentieri molto meno impervi, e che invece ha deciso di dire ciò che ha in cuore in modo del tutto originale, sia apprezzata come merita, perché se la poesia italiana non ritroverà questo afflato civile e così antropologicamente connotato, rischierà di diventare ancora più irrilevante di quanto non lo sia già oggi.
Non perdere i nostri aggiornamenti
Elaboreremo i dati personali forniti in conformità con la nostra politica sulla privacy.
Articoli Recenti
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO
KAFKA, GLI OTTO QUADERNI IN OTTAVO o la consistenza dell'individualità di Francesca Sallusti Questa opera ha il suo principio
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE
VAN GOGH, PALAZZO BONAPARTE di Francesca Sallusti Apre la mostra una sala dedicata a pittori coevi a Van gogh, come Renoir
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI
FRANCESCA SALLUSTI, NOTTURNI SPLENDENTI Testo poetico di Francesca Sallusti sull'opera di Gianmaria De Luca DA "MAAM - MUSEO DELL'ALTRO E DELL'ALTROVE" di Gianmaria De Luca
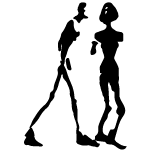


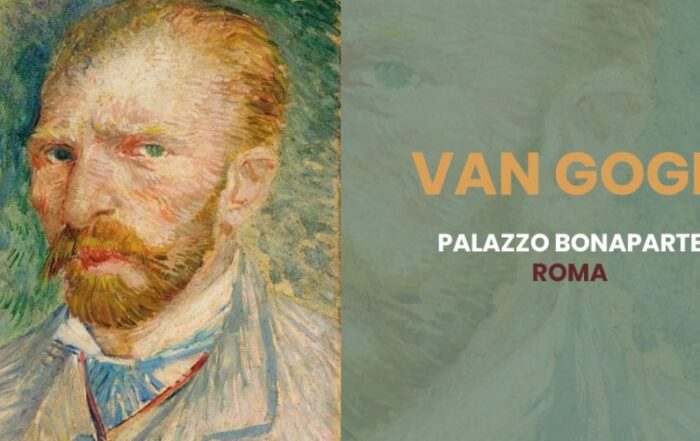

Scrivi un commento